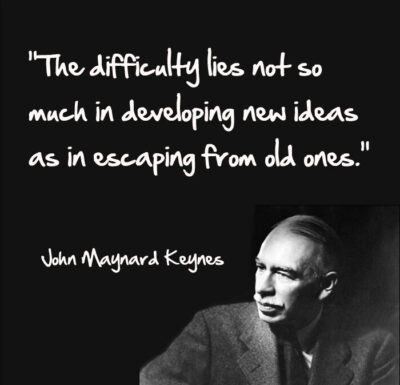Dopo aver analizzato la fondamentale ispirazione neoliberista della legge sulla Buona Scuola (La perversione neoliberista e la legge della “Buona Scuola”), occorre ora comprendere da dove arrivi questa impostazione ideologica.
Sarebbe un errore pensare che la curvatura in senso neoliberista impressa alla scuola italiana negli ultimi 20 anni sia una scelta autonoma dei politici nazionali. È certamente una loro responsabilità ed un effetto della loro ignavia, ma l’origine della scuola neoliberista è da ricercarsi nel modello di Europa che è stato realizzato a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso. Nei trattati europei – il Trattato sull’Unione europea (TUE), del 1986, confluito nel Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), del 2007 – non si parla di una politica europea dell’istruzione. L’Articolo 165 del TFUE (ex articolo 149 del TCE) afferma al comma 1:
L’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
Non si parla, cioè di un indirizzo comune fra gli Stati europei, ma di una generica collaborazione fra Stati con completa autonomia in materia di istruzione. L’idea di imprimere una direzione comune alle politiche scolastiche matura al di fuori delle istituzioni europee, in alcuni circoli privati di industriali.
Se si vuole situare la nascita di una politica comune in Europa non è alla Commissione europea, al Consiglio dei ministri e ancora meno al Parlamento europeo che dobbiamo guardare quanto, piuttosto, alla potente lobby padronale della Tavola Rotonda Europea degli industriali (ERT). Creato nel 1983, questo gruppo di pressione riunisce una quarantina tra i più potenti dirigenti industriali europei, come Peter Brabeck (Nestlé), Paolo Fresco (Fiat), Leif Johansson (Volvo), Thomas Middelhoff (Bertelsmann), Peter Sutherland (BP) o Jürgen Weber (Lufthansa). Il loro lavoro comune consiste nell’analizzare le politiche europee nell’ambito dei diversi settori e nel formulare raccomandazione corrispondenti ai propri obiettivi strategici. Alla fine del 1989 un «gruppo di lavoro educazione» dell’ERT pubblica un rapporto intitolato «Educazione e competenza in Europa». Questo sarà il primo di una lunga serie di documenti ad affermare «l’importanza strategica vitale della formazione e dell’educazione per la competitività europea» e a perorare «un rinnovamento accelerato dei sistemi d’insegnamento e dei loro programmi».
In particolare vi si legge che «l’industria non ha che un’influenza molto debole sui programmi impartiti», e che gli insegnanti hanno «una comprensione insufficiente dell’ambiente economico, degli affari e della nozione di profitto», che «non comprendono i bisogni dell’industria» [ERT 1989]. Comunque, insiste la Tavola Rotonda, «competenza ed educazione sono fattori di riuscita vitali». In conclusione, la lobby padronale suggerisce di «moltiplicare i partenariati tra le scuole (e) le imprese». Invita gli industriali a «prender parte attiva allo sforzo educativo» e chiede ai responsabili politici «di coinvolgere le industrie nelle discussioni concernenti l’educazione» [ERT 1995].
La Tavola Rotonda rimprovera anche che «nella maggior parte d’Europa, le scuole (siano) integrate in un sistema pubblico centralizzato, gestito da una burocrazia che rallenta la loro evoluzione o le rende impermeabili alle domande di cambiamento provenienti dall’esterno» [ERT 1995]. I datori [di lavoro] reclamano dei lavoratori «autonomi, in grado di adattarsi ad un continuo cambiamento e di accettare senza posa nuove sfide» [ERT 1995].
[Nico Hirtt, L’Europa, la scuola e il profitto. Nascita di una politica educativa comune in Europa, http://www.edscuola.it/archivio/ped/europa_scuola_profitto.htm, traduzione di Paola Capozzi]
Troviamo qui la retorica che accompagnerà tutti i documenti europei successivi: la scuola è finalizzata all’economia e al lavoro, è al servizio dell’industria, coinvolge gli imprenditori nello sforzo educativo, è orientata alla competizione e al profitto, deve rinnovarsi velocemente, deve formare lavoratori autonomi e flessibili, sempre pronti ad adattarsi ai cambiamenti (senza gravare per la formazione sulle imprese) e impegnati nell’educazione permanente.
Un decennio dopo la creazione dell’ERT, nel 1992, il Trattato di Maastricht affida alla Commissione europea (organo non elettivo, ricordiamolo) il compito di delineare una politica europea dell’istruzione:
l’articolo 126 del Trattato di Maastricht accorda per la prima volta alla Commissione europea competenze in materia di insegnamento. A tal fine viene creata la DGXXII, la Direzione generale dell’Educazione, della Formazione e della Gioventù, diretta dalla socialista francese Edith Cresson. Si tratta di una sorta di «ministero» europeo dell’Educazione. Mme Cresson mette rapidamente in azione un «gruppo di riflessione sull’Educazione e la formazione» sotto l’egida del prof. Jean-Louis Reiffers. Dopo aver direttamente partecipato all’elaborazione del Libro Bianco «Insegnare e imparare: verso la società cognitiva», tale gruppo, nel 1996, esprime le proprie raccomandazioni. Si legge che «è adattandosi alle caratteristiche dell’impresa dell’anno 2000 che i sistemi d’educazione e di formazione potrebbero contribuire alla competitività europea e al mantenimento dell’occupazione.» [REIFFERS 1996]. (Ibid.)
La Commissione europea, insomma, mette nero su bianco le indicazioni degli industriali. Emergono continuamente come finalità dell’istruzione l’adattamento alle esigenze delle imprese, l’occupazione e la competitività. Nel 2000, a Lisbona, si esalta l’e-learning come nuova frontiera dell’insegnamento e si tracciano gli obiettivi economici della futura “società della conoscenza”:
L’idea madre, l’ideologia fondatrice di questa politica educativa comune, è riassunta come segue nella maggior parte di questi documenti: «l’Unione europea si trova di fronte ad una svolta formidabile indotta dalla mondializzazione e dalle sfide relative a una nuova economia fondata sulla conoscenza». Da quel momento l’insegnamento europeo deve piegarsi ad un «obiettivo strategico» principale: aiutare l’Europa a «diventare l’economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di una crescita economica duratura» [CCE 2001]. (Ibid.)
I cardini delle politiche europee (della Commissione, beninteso) per la scuola sono quindi perfettamente collocabili nel quadro dell’ideologia neoliberista: poiché tutta la realtà umana va guardata esclusivamente da una prospettiva economica, la competizione economica è il fine dell’istruzione. Appare quasi superfluo osservare che questo modo di intendere l’istruzione è lontanissimo dalla visione della scuola come organo costituzionale, che forma uomini e cittadini alla vita democratica e trasmette la cultura da una generazione all’altra, quale è delineata dalla Costituzione italiana del ‘48.
Il virus neoliberista penetra in ogni meandro del linguaggio dei documenti europei, contaminando alla radice tutto ciò che nella Costituzione parla di cultura, solidarietà, cooperazione, inclusione, partecipazione democratica, diritti, uguaglianza sostanziale.
Si parla di competenze professionali (nelle nuove tecnologie informatiche, nelle lingue, nello spirito d’impresa, nella pluridisciplinarietà) e sociali («fiducia in se stessi, indipendenza, attitudine ad assumersi rischi» CCE 2000-b), di formazione permanente (sviluppando le competenze di base e la capacità di imparare e facendo così risparmiare le imprese sulla formazione), di alfabetizzazione informatica ed e-learning, di deregolamentazione e decentramento dei sistemi di istruzione nazionali, per renderli “flessibili” e metterli in concorrenza fra loro, di partnerariato con le imprese («Gli istituti scolastici, i centri di formazione e le università dovrebbero essere aperti sul mondo: è opportuno assicurare i loro legami con l’ambiente locale, con le imprese e con i datori di lavoro in particolare, per migliorare la comprensione dei bisogni di questi ultimi e accrescere in questo modo l’occupabilità dei discenti» [CCE 2001]), di diversificazione dell’offerta, per venire incontro a bisogni diversi e «creare sistemi elastici di validità dei titoli» [Présidence du Conseil européen, 2000] (ovvero, indebolire il valore legale del titolo di studio, per aumentare la flessibilità e ridurre le tutele), di mobilità degli studenti, ottimo alibi per l’armonizzazione dei percorsi di studi e per un controllo europeo dell’insegnamento, di cittadinanza e impegno sociale (obiettivo che però poi tende ad indebolirsi nei documenti successivi) e di lotta all’esclusione, da attuare in tre modi: la sponsorizzazione delle scuole da parte di imprese, le convenzioni d’inserimento scuola-impresa (ecco lì l’alternanza scuola-lavoro), l’attuazione di tecnologie educative di punta [CCE 1995].
In un contesto di feroce competizione economica e di continua innovazione tecnologica, se la scuola è finalizzata all’impresa si producono due conseguenze: la prima è che diventano necessarie figure di professionisti ad alta specializzazione tecnologica, la seconda è che la precarizzazione del lavoro aumenta la richiesta di personale a bassa qualifica e con contratti a termine. Il mondo economico neoliberista richiede una scuola duale, nella quale gli estremi si allontanano sempre di più. Il dualismo formativo si accompagna alla terza conseguenza della competizione economica: la riduzione della spesa sociale come conseguenza della riduzione della pressione fiscale richiesta dalle imprese, per sostenerle nella competizione globale (“defiscalizzazione competitiva”). La scuola neoliberista è competitiva e ridotta all’essenziale e convive con una pluralità di enti privati che erogano formazione. Così anche l’insegnamento diventa un mercato e la deregulation coinvolge l’istruzione:
Per la Tavola Rotonda degli Industriali, « la resistenza naturale dell’insegnamento pubblico tradizionale dovrà essere superata attraverso l’utilizzo di metodi che combinano l’incoraggiamento, l’affermazione di obiettivi, l’orientamento verso l’utente e la concorrenza, soprattutto quella del settore privato » [ERT 1989]. (Ibid.)
Di qui l’insistenza sulle competenze, anziché sulle conoscenze e sulla cultura:
Lo scivolamento dei saperi verso le competenze è spiegato quindi non da un sussulto d’innovazione pedagogica, come si potrebbe ritenere, ma essenzialmente da una volontà di adeguamento della mano d’opera ad un ambiente di produzione caotico e dualizzato. Per quel 20-25% di manodopera che occuperà i posti a un livello molto alto di qualificazione, i saperi scolastici sono per lo più obsoleti. Per il 40- 50% dei posti a livello di qualificazione molto basso, sono superflui. Dal che la volontà di concentrare la formazione su quelle competenze di base comuni a tutti: lettura, scrittura, calcolo, alfabetizzazione informatica, adattabilità, capacità di risolvere problemi, competenze sociali, etc… (Ibid.; corsivo mio)
Ecco spiegato perché il governo Berlusconi, con la Ministra dell’Istruzione Letizia Moratti, si pose dal 2001 come obiettivi il ridimensionamento del ruolo dello Stato nell’ambito dell’istruzione e la concorrenza fra scuola pubblica e privata; la riduzione della spesa per l’istruzione, diminuendo le risorse, il numero dei docenti, delle ore di scuola, in particolare il tempo prolungato e il tempo pieno; il mantenimento del sistema scolastico tradizionale, rigidamente costituito in ordinamenti separati (legge delega n.53 del 2003, solo parzialmente applicata per l’opposizione serrata dei docenti), con la scelta precoce della scuola superiore a 13 anni; la riduzione delle ore di lezione a 27 settimanali; il ritorno al maestro unico di ottocentesca memoria (tutor); l’anticipo della frequenza nella scuola d’infanzia; la progressiva sparizione del tempo pieno; nuovi programmi che, allegati alla legge, diventavano obbligatori, in palese contrasto con la norma, ancora vigente, sull’autonomia scolastica; la creazione di un sistema secondario duale, con la rigida separazione fra i licei, sotto il controllo dello Stato, e gli istituti tecnici e professionali, affidati alle Regioni (D. Lgs. n. 226 / 2005).
Ed ecco l’origine del patetico slogan di quegli anni, le tristemente famose “tre ‘i’” della Moratti: Inglese, Informatica e Impresa. In queste tre parole si sintetizza un intero programma politico europeo, imprigionato dalla retorica neoliberista, e la fine della scuola come organo costituzionale, produttrice di cultura, di cittadinanza democratica e di uguaglianza sostanziale di cui parlava il padre costituente Piero Calamandrei.
È lo stesso paradigma che porta qualche anno dopo il Ministro dell’Economia Tremonti e la Ministra dell’Istruzione Maria Stella Gelmini (altro governo Berlusconi) ad una pseudo-riforma (legge 133/2008) che ha come unico criterio il massiccio de-finanziamento della scuola pubblica, già intrapreso da Letizia Moratti. Più che di una riforma, si tratta di una scientifica e draconiana amputazione della scuola pubblica a fini di bilancio e – meno dichiarato – di indebolimento del sistema pubblico di istruzione, che da allora agonizza in mezzo a ristrettezze infinite.
In pochi minuti di Consiglio dei ministri, nel luglio 2008 Tremonti ottiene senza battere ciglio 8 miliardi di euro di tagli alla scuola sui 40 del bilancio complessivo. Nessun comparto pubblico verrà devastato con altrettanta determinazione:
- 87.000 insegnanti in meno (licenziati in tronco, perché precari), 44.000 ATA (amministrativi e bidelli) in meno, aumento del numero degli alunni per classe, con classi di 30-40 alunni, riduzione del numero di ore delle materie, taglio del tempo pieno e dei moduli alla scuola primaria (con conseguenze gravi soprattutto al Sud nelle terre di mafia), taglio dei laboratori ai tecnici e ai professionali, saturazione delle cattedre a orario pieno (con conseguente discontinuità didattica), aumento del precariato, blocco delle assunzioni per concorso e delle carriere dei docenti, revisione al ribasso dei programmi, con la neutralizzazione di ogni prospettiva critica e con l’indebolimento massiccio dello studio della storia;
- ritorno alla scuola ottocentesca con il maestro unico nella scuola primaria, il ritorno dei voti numerici, abrogati nel 1977, e riordino della scuola superiore basato sulla Riforma Moratti, con la sua rigida separazione ordinamentale, ignorando i frutti positivi delle sperimentazioni degli anni ‘90;
- riduzione drastica dei fondi alle scuole, che minaccia il principio di gratuità dell’istruzione (per sopravvivere, le scuole chiedono contributi sostanziosi alle famiglie).
Nonostante una fortissima protesta nel Paese, che raccoglie centinaia di movimenti spontanei di docenti, studenti e genitori, organizzazioni sindacali, prese di posizione politiche, la “riforma” viene condotta a termine senza alcun cedimento, con un atteggiamento autoritario e sprezzante che non ha eguali nella storia repubblicana. Gli effetti non tardano a farsi sentire:
- l’autonomia scolastica viene fiaccata dalla mancanza di fondi;
- vengono cancellate tutte le compresenze, utili per i progetti di recupero e integrazione scolastica;
- il tempo pieno e la specializzazione dei docenti nei moduli, fiore all’occhiello della scuola primaria, vengono ridimensionati o cancellati (il tempo pieno praticamente sparisce al Sud), lasciando il posto al maestro solo e tuttologo (più che unico), allo spezzatino didattico (suddivisione di parti di orario fra diversi docenti per coprire i buchi di orario nelle classi), alle classi-pollaio, all’impossibilità di garantire il servizio di pre-scuola e a volte la stessa vigilanza degli alunni per carenza di bidelli;
- l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria cessa di essere affidato ai 9000 docenti specialisti con formazione specifica in Lingue, per essere assegnato alle docenti di classe dopo 30 ore di formazione;
- gli istituti tecnici e professionali perdono gran parte delle ore di laboratorio;
- i licei si vedono ridurre le ore di scuola; alcune materie, come la storia e la filosofia, vengono ridotte nel monte-ore, con modifiche alla distribuzione della materia nei cicli di scuola e nelle classi della secondaria superiore che rendono impossibile trattare il Novecento, che resta quindi solo sulla carta delle Indicazioni Nazionali;
- le sperimentazioni più moderne, capaci di favorire un pensiero critico e complesso, come il Liceo delle Scienze sociali, vengono sostituite da percorsi di studio molto meno consistenti dal punto di vista culturale e svuotati di ogni potenziale critico, come avviene con il Liceo delle Scienze umane, che ripropone, con nome diverso ma eguale ideologia di fondo, il vecchio Istituto Magistrale di gentiliana memoria, una sorta di liceo femminile di serie B.
Nella cronica mancanza di fondi, le scuole vanno avanti di emergenza in emergenza, attingendo ai contributi semivolontari delle famiglie e al volontariato dei docenti, che continuano a fare le stesse cose di prima o gratis o con un compenso da caporalato di Stato.
Questo il quadro desolante nel quale si inserisce la Buona Scuola di Renzi a completare l’opera. La perversione ideologica che sostiene questa visione stravolta ed eversiva della scuola democratica consiste nello spacciare per positivo e vantaggioso proprio ciò che toglie alle future generazioni ogni speranza di riscatto umano e sociale.
L’ossessivo mantra della formazione per il lavoro, della competizione, della centralità delle nuove tecnologie (TIC), del cambiamento a tutti i costi, della partecipazione delle imprese nei programmi e nella didattica, per esempio attraverso l’alternanza scuola-lavoro e il finanziamento privato della scuola pubblica, del rinnovamento dei metodi di insegnamento a favore dello sviluppo delle competenze, dell’educazione permanente, rappresentano il belletto con il quale si maschera una realtà sociale data per scontata e immodificabile, fondata sul profitto ad ogni costo, sulla subalternità di ogni valore al denaro, sullo sfruttamento del lavoro, sul controllo delle coscienze, sull’addestramento di una manodopera docile e complice del proprio asservimento, sul furto di cultura e di identità, sull’impoverimento del sapere.
Negli anni, il mantra si ripete sempre uguale. Questo dice, per esempio, il Progetto dell’UE per la modernizzazione dell’istruzione superiore (COM/2011/567) del 2011:
L’insegnamento superiore incrementa il potenziale individuale e deve dotare i diplomati delle conoscenze e delle competenze trasferibili essenziali che consentiranno loro di riuscire ad ottenere posti altamente qualificati. Tuttavia, i programmi d’insegnamento reagiscono spesso con lentezza all’evoluzione delle esigenze dell’economia in generale e non riescono ad anticipare le carriere del futuro, né a contribuire a modellarle; i diplomati fanno fatica a trovare un impegno di qualità che sia conforme ai loro studi. Associare i datori di lavoro e le istituzioni del mercato del lavoro alla definizione e alla realizzazione dei programmi, sostenere gli scambi di personale e introdurre l’esperienza pratica nei corsi può aiutare ad adattare i programmi di studio alle necessità attuali e future del mercato del lavoro, favorendo l’occupabilità e lo spirito imprenditoriale. Un migliore controllo da parte degli istituti d’istruzione dei percorsi di carriera dei loro ex studenti può fornire importanti informazioni sull’elaborazione dei programmi e migliorare la loro pertinenza. (corsivo mio)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0567
Alla persona comune, può sembrare lodevole che la scuola fornisca competenze spendibili nel mercato del lavoro e diffonda l’uso delle tecnologie digitali, ma questa convinzione si fonda su un colossale inganno: un sapere funzionale all’economia perde infatti ogni funzione emancipante e priva gli studenti della creatività, del pensiero critico, del senso della propria libertà interiore e civile che rende possibile la consapevolezza, la ribellione e la costruzione di un mondo migliore. Alla lunga, mina il senso stesso dell’identità culturale di un popolo e produce lavoratori standardizzati, flessibili, senz’anima e disposti a consegnare le loro precarie esistenze ad una globalizzazione che segue unicamente la legge del mercato. Il nemico della scuola neoliberista non è l’ignoranza, ma la democrazia.
Il confronto fra il dettato costituzionale, che ci descrive il dover essere della scuola democratica, e l’implicita costituzione neoliberista, che invece è a fondamento della scuola reale, frutto del colpo di mano della burocrazia europea e degli industriali, sarà oggetto di ulteriore riflessione.